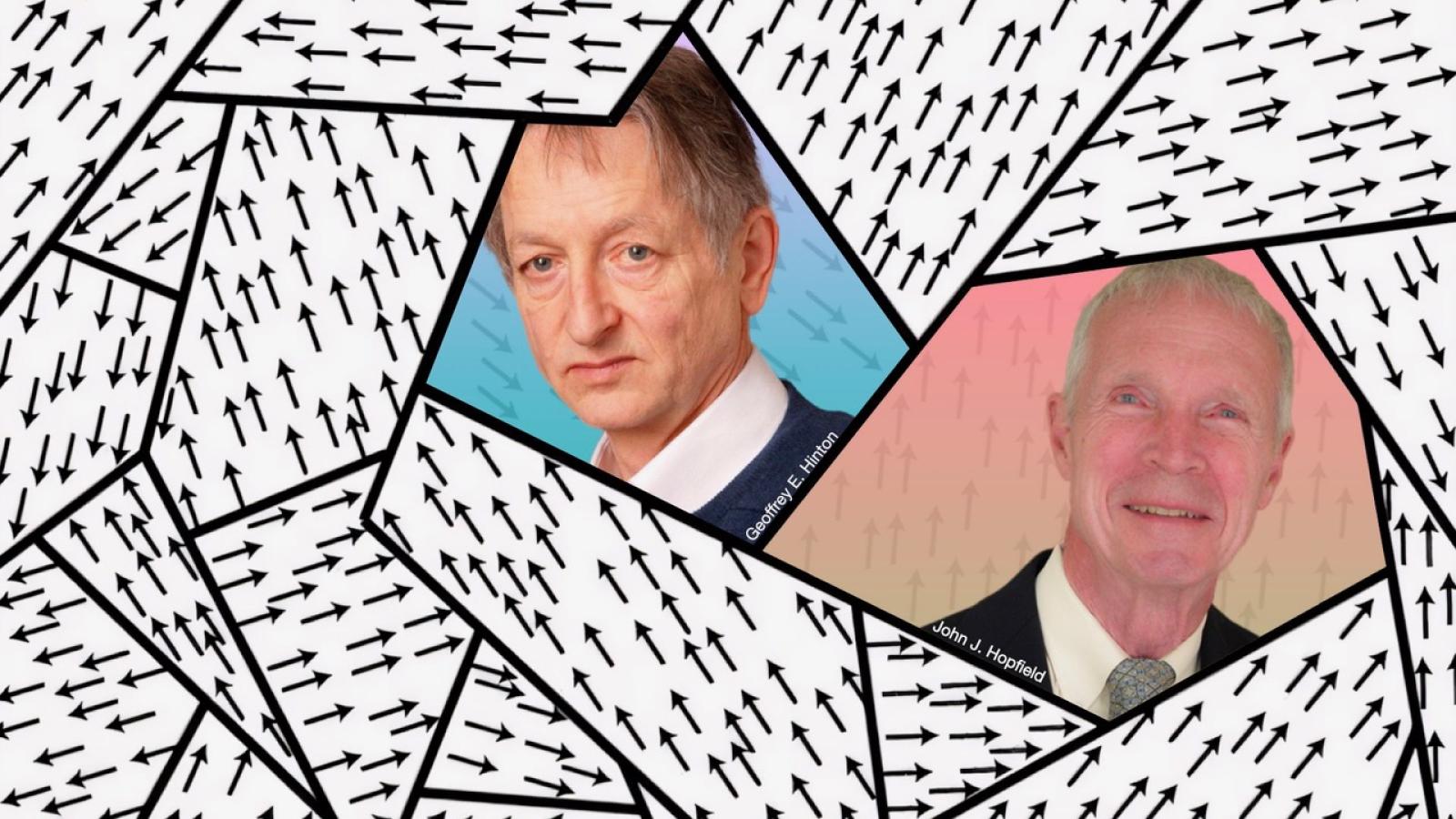Ancora una volta, è uno scienziato il protagonista di questo romanzo di Giuseppe O. Longo (La gerarchia di Ackermann, Jouvence, Milano, 2016, pagg. 365, € 20,00),1 come già accadeva in Di alcune orme sopra la neve2 e L’acrobata.3 Ma qui il giovane fisico e il matematico nel pieno dell’attività scientifica lasciano il posto a una figura dolente e problematica di scienziato di mezz'età, spinto dagli eventi a gettare uno sguardo intenso sul passato e a tentarne un bilancio.

La circostanza da cui muove la sua lunga meditazione è l’arrivo di un misterioso plico dall’Ungheria: privo di ogni indicazione relativa al mittente, esso resterà in primo piano lungo tutto il romanzo, e sarà protagonista del finale.
"Il plico ricevuto da Budapest l’altro ieri se ne sta ancora lì, sul tavolino degli scacchi, anzi ho dovuto spostare un po’ i pezzi per far posto al plico, quindi non è esatto dire che a casa mia la scacchiera è sempre pronta per una partita, adesso per esempio non è pronta, e comunque fra i bianchi e i neri si frappone il grosso plico giallo che non ho ancora avuto il coraggio di aprire, caro Farkas, quindi non so che cosa contenga, anche se posso tentare di immaginarlo. E’ chiaro che prima o poi lo aprirò, forse già questa notte, visto che il sonno non viene".4
A questo plico, come è intuibile, viene assegnata dall’autore una valenza simbolica profonda e mutevole. Innanzitutto, esso contiene forse la chiave di un enigma, la spiegazione di un mistero: ma questo enigma e questo mistero hanno contorni vaghi, possono assumere caratteristiche molto diverse, forse sono insolubili o addirittura sono privi di senso. In ogni caso, essi riguardano una vicenda di molti anni prima, quando il protagonista visse per un breve periodo in Ungheria per sviluppare le proprie ricerche nel campo della matematica: su quella “gerarchia di Ackermann”, appunto, che dà il titolo al volume.
Il passato che ritorna con un plico da Budapest
Ma come guardare al passato? Questa è la domanda mai esplicitamente posta, che però domina la ricerca incessante che struttura un’intera giornata di Guido Marenzi - il protagonista - subito dopo l’arrivo del plico misterioso. La più immediata pista di indagine sul passato è quella che potremmo definire “poliziesca”, aggiungendo che lo sguardo di Guido è quello dello scienziato e dell’appassionato giocatore di scacchi. Che cosa è veramente accaduto vent’anni prima in Ungheria, al di là e soprattutto dietro la travolgente relazione del protagonista con la bella Eva Farkas? Quella che egli ha vissuto come una propria colpevole trasgressione non era forse, in realtà, l’esito inevitabile di una trama pazientemente intessuta dal marito di lei, con la complicità del suo losco compare Kühlmorgen, per liberarsi della moglie? Questo rovesciamento di prospettiva, che emerge a poco a poco dalla riflessione, porta Guido Marenzi sulla strada dell’inquieto vaglio di ogni indizio, di ogni traccia, nel ricordo di gesti, parole, allusioni.
Con una memoria lucidissima, quasi proustiana nella sua implacabile rievocazione dei più minuti dettagli, egli interroga retrospettivamente con uno sguardo nuovo conversazioni, incontri, relazioni. Una scrittura assai efficace rende questa ricerca, che occupa una parte rilevante del romanzo, un'esperienza emotiva molto coinvolgente per il lettore. Particolarmente efficace è il lungo monologo (rivolto ad un Guido Marenzi attento ad ogni sfumatura) di Kühlmorgen in trattoria. Questa indagine (che ad un certo punto giunge ad assumere addirittura l’andamento strutturale e linguistico di un interrogatorio di polizia) porta il protagonista a conclusioni inattese: tutto è possibile, nel senso che ogni ipotesi, anche la più sconcertante, è suffragata da qualche indizio.
Così, lui traditore è stato, forse, tradito dalla moglie con l’enigmatico Kühlmorgen, complice di un Farkas ansioso di liberarsi di Eva per mezzo dell’amante o, addirittura, del veleno; ma potrebbe essere stata invece Eva ad avvelenare il marito, a poco a poco... O forse era soltanto lui, Guido, il colpevole?
"Un vuoto, uno stordimento, un ondeggiare. Dov’erano i buoni e i cattivi? Tutto si confondeva. Avrebbe voluto ripetere tutte le mosse per capire quella sbagliata, là dove si annidava la smagliatura della sconfitta. Si era sempre immaginato buono ma forse, in quella partita, il cattivo era lui. E quella volta sul Balaton. E il palazzo dove abitavano i Farkas, nella Köfaragó utca, come si poteva immaginare che quel palazzo non c’entrasse per nulla, con quei cortili, con quelle ringhiere. E quella neve sporca sulla Várhegy". 5
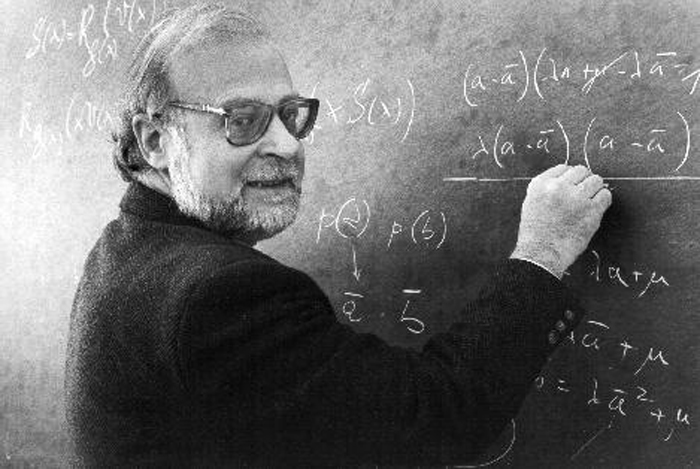
Giuseppe O. Longo (Forlì, 2 marzo 1941): cibernetico, teorico dell'informazione, epistemologo, divulgatore scientifico, scrittore, attore e traduttore. Docente all'Università di Trieste, ha introdotto la teoria dell'informazione nel panorama scientifico italiano.
Chi è dunque il colpevole in questa storia che, a vent’anni di distanza, ancora tormenta il protagonista con lancinanti sensi di colpa? Perché, a questo punto, non aprire il plico, che potrebbe contenere la soluzione, la spiegazione di questa intricata vicenda? Ma, dopo tanto cercare, è il respiro stesso della propria indagine che appare inadeguato a Guido Marenzi. Improvvisamente, infatti, egli coglie nelle lontane vicende ungheresi un aspetto diverso: l’inizio di una crisi personale che nel corso degli anni successivi si è aggravata, fino a portarlo al divorzio, all’etilismo e al sostanziale abbandono dell’attività scientifica. E’ questa crisi, dunque, che egli deve ripercorrere, immergendosi nei propri ricordi, lasciandosi trasportare all’interno della rete di associazioni tra pensieri. La giornata di Guido, così, prende ad assomigliare sempre più a quella di un Ulisse di fine millennio, per certi aspetti simile, ma per altri aspetti diverso dal Leopold Bloom joyciano.
Guido Marenzi, infatti, è e resta uno scienziato, e dunque è acutamente consapevole del fatto che la rete delle associazioni tra pensieri è assai più lasca e indefinita delle reti concettuali della scienza. In particolare, tra le associazioni non c’è gerarchia, a differenza di quell’universo strutturato che dà il nome al romanzo. E questo lo affascina ma, insieme, lo angoscia. Assistiamo ad una singolare compresenza di opposti, nella giornata di questo Bloom scienziato: egli lascia vagare i suoi pensieri mentre gioca a scacchi col giovane matematico Stefano Tramer, il suo compagno abituale, e vincola così il suo vagare a una attività non meno strutturata della dimostrazione di un teorema.
Ancora una volta, la scrittura di Longo propone e sostiene efficacemente l’esplorazione del nuovo percorso di conoscenza.
"Chiuse la porta. Mise la chiave in tasca, si toccò la tasca posteriore. Il portafogli. L’altra tasca, il fazzoletto. Scesero le scale, via via più scure. Grandi finestre sul cortiletto interno. Odore di pasticceria. Adesso Tramer vorrà andare in pasticceria. La sua golosità. Forma di compensazione. Infanzia infelice. Senza padre. Farkas voleva lo zucchero, Tramer vuole le paste. Da nobis hodie Domine. Paste pater. Manca il padre. La sua Giocasta. Groviglio di complessi, Edipo e tutto. Giocasta è troppo forte, nessun’altra donna va bene. Forse quella che gli dà le paste. Sandra Liessi. Forse la Sandra pasticciera, bionda, burrosa, bombata".6
Ma questi pensieri in libertà non hanno la leggerezza che auspicava il protagonista de L'acrobata, un precedente romanzo di Longo. In esso, il protagonista sognava:
"Avevo chiuso gli occhi, mi vedevo sul filo, ero l’acrobata vestito di cuoio, con l’asta di equilibrio, camminavo con circospezione, sentivo la corda sotto la suola sottile della scarpa, vedevo in basso la folla attonita e sospesa, vedevo i volti e sapevo che quei volti dovevano sparire […] e quando tutti quei volti fossero spariti avrei potuto cominciare a far sparire la città, e le montagne e il mondo. E dopo avrei potuto camminare ovunque, e non solo sul filo".7
L'impossibile leggerezza
Un tema comune lega i protagonisti dei tre romanzi citati: la ricerca di un'impossibile leggerezza, di un'irraggiungibile trascendenza rispetto alla pesantezza della materia. Per Enrico, il fisico protagonista del primo di essi, la ricerca scientifica appare improvvisamente niente più che la sfocata immagine di un’altra ricerca, ben più importante e vitale.8
"Quand’anche la fisica […] risolvesse tutti i problemi veri, quelli cioè di cui la fisica può occuparsi, l’uomo sarebbe soddisfatto? Quei vecchi problemi dell’origine dell’universo, del significato della vita, del nostro destino, che da secoli travagliano la nostra mente e il nostro cuore, resterebbero lì a guardarci con occhi inquieti, nonostante gli scongiuri e gli esorcismi in apparenza tranquillizzanti ma in realtà vagamente isterici della scienza? […] Forse la ricerca non era poi quell’attività specialissima e inebriante che aveva creduto, forse quello che aveva considerato un lento e faticoso avvicinamento alle tangibili verità della materia non era altro che un vagabondaggio casuale da una piccola illusione all’altra".9
La ricerca scientifica, quindi, aveva costituito per Enrico un modo per tentare di uscire da uno stato di prigionia e di oppressione.
"Gli pareva che la sua vita attuale fosse solo una fase transitoria, un passaggio obbligato per giungere in un territorio più luminoso e immateriale".10
E’ l’antica e affascinante immagine dell’“armonia delle sfere” a suggerire ad Enrico un modo diverso di guardare il mondo e a spingerlo verso i confini: verso il muro di cinta del Laboratorio e al di là di esso. Ma in questo viaggio Enrico si perde, ed è con un misto di sollievo e di ansietà che scorge, appunto, “alcune orme sopra la neve”.
Il protagonista del romanzo L’acrobata è un po’ un Enrico vent’anni dopo: un Enrico che ha percorso la carriera accademica e, da giovane borsista, è diventato professore. In un certo senso, i suoi interessi professionali sono più leggeri, più immateriali (infatti, non studia la materia, ma è un esperto di crittografia), e anche le inquietudini esistenziali di Enrico sembrano essersi pacificate. Egli è sulle tracce di una macchina per la decodificazione universale che si dice sia stata messa a punto dai nazisti: una macchina dall’emblematico nome di “Enigma”. Questa ricerca è iniziata come un’appassionata indagine di storia della scienza, sulla scorta di un'enigmatica (enigmatica, appunto) fotografia rubata in un museo di Tallinn, in Estonia. Dunque, come Guido Marenzi, anche questo scienziato senza nome ci viene presentato alle prese con una ricerca indiziaria di taglio quasi poliziesco, emblematica della ricerca scientifica. Ma, già nel primo romanzo, un enigmatico tipografo abitatore del sottosuolo aveva ammonito Enrico: la ricerca è necessaria, ma non bisogna pensare che essa ci porti veramente a ciò che cercavamo.
E' quello che sperimenta anche il protagonista de L’acrobata quando scopre in modo inaspettato un esemplare dell’Enigma in un laboratorio vicino a Vienna.
"Ero finalmente davanti all’oggetto delle mie ricerche, ma non provavo nessuna emozione: freddezza, piuttosto, o apatia, come se avessi aspettato troppo e l’attesa mi avesse svuotato".11
In un certo senso, è proprio in quel momento che si svela tutta la pregnanza simbolica dell’Enigma, ma nello stesso tempo anche la sua irrilevanza come oggetto concreto. Il protagonista de L'acrobata è preso dalla stessa ansia ascetica di Enrico, e si propone di spogliarsi di tutto, per giungere, attraverso il silenzio, a un misterioso e personale mondo nuovo. Questo cammino iniziatico verso il distacco, la leggerezza, il nulla fa pensare a un'esperienza mistica che non conosce il proprio nome.
"Gödel ha messo a nudo la debolezza della nostra anima"
Come già sappiamo, anche Guido Marenzi è uno scienziato. Egli è acutamente consapevole della fine ormai irreparabile del sogno di certezza della scienza.
"Frugando nell’abisso e mettendo a nudo la roccia friabile e dolente dei fondamenti della matematica, Gödel ha messo a nudo la debolezza della nostra anima, come le radici di un albero rovesciato. E queste radici si contorcono e si arricciano, sono vermi sotto la pioggia, caro mio. Fissando questi vermi troppo da vicino alcuni di quei grandi pensatori sono impazziti. Il delirio da matematica. Altro che ordine rassicurante, altro che sconfitta del caos".12
La fine delle certezze scientifiche, simbolizzata nel romanzo La gerarchia di Ackermann dall’impossibilità di chiarire in modo univoco le vicende di vent’anni prima, sembra non avere altro possibile esito se non quello di lasciarsi trasportare dal fiume dei ricordi, quello di raccontare i propri pensieri. La giornata di Guido Marenzi, così lucidamente e felicemente narrata da Longo, assume dunque un significato che trascende la vicenda individuale per assumere un valore di meditazione sulla fine di un pensiero forte sorretto e strutturato dalla scienza. Ci viene proposto, dunque, un passaggio dall'enunciazione delle certezze alla narrazione dell’esperienza? Questa prospettiva, così presente nel dibattito epistemologico del Novecento, è fatta propria da Guido Marenzi.
"Io non faccio altro che ricapitolare la mia vita, continuo a raccontare la storia della mia vita per ricucirne i brandelli. La mia storia, spezzettata e tritata, partorisce tante piccole storie. E’ una continua narrazione, un po’ demenziale, se vuole, ma allo stesso tempo salutare. Può sembrarle assurdo, ma raccontandomi queste storie della mia vita dimentico la mia vita, trovo un attimo di requie. […] Qualcuno va dallo psicanalista, anch’io per un certo periodo ci sono andato, andavo da Curiel, lo conosce, no? E lo psicanalista che cosa fa? Ci racconta delle storie. Altri per guarire dal male di vivere scrivono dei libri, cioè narrano delle storie. Non cerchiamo più la verità inenarrabile e assoluta. Ciascuno cerca la propria verità, la narra con gli occhi e con il cuore, col suo disagio e la sua rassegnazione".13
Ricucire i brandelli della propria storia: questo il tentativo di Guido. Ma, come si è accennato in precedenza, non si tratta di un cammino di leggerezza: spesso pare che i ricordi vadano alla deriva, senza ordine né struttura.
"Queste le mie riflessioni, i miei ricordi. Relitti di un naufragio, tavole galleggianti su un mare oleoso, chiazze di ruggine iridescenti, bolle gorgoglianti da putredini nascoste".14
I pensieri in libertà, dunque, minacciano continuamente di portare alla luce putredini nascoste, di spalancare porte segrete da molto tempo chiuse; dietro di essi c’è mistero e, ancora una volta, colpa. Il Castello di Barbablù di Béla Bartók, di cui Guido ricorda a memoria i versi in ungherese, diviene così l’immagine di un regno dell’inconscio intriso di sangue e di irrimediabili delitti.
"Giuditta chiede con insistenza le chiavi, ma Barbablù non vuole, non vuole assolutamente dargliele, la mette in guardia, ma non c’è niente da fare, quella insiste, e così dopo molte esitazioni e inviti alla prudenza le consegna la prima chiave, togliendola da un mazzo pesante, legato da un nastro rosso, e questo rosso significa già qualcosa, è già un segno".15
Il collegamento con il divieto di aprire le stanze segrete chiarisce ancora meglio l’impossibilità, da parte del protagonista, di aprire il plico misterioso. Infatti, l’immagine del passato che di qui emerge è quella di un mondo ormai pietrificato e irrimediabile di sangue e di colpa: l’angoscia intollerabile dello svelamento della verità del passato sembra impedirne ora un'elaborazione. Alla fine, Guido getterà il plico nel Canal Grande. Si illuderà di avere liberato in questo modo il proprio pensiero e la propria vita da un incubo onnipresente, da un gravoso fardello di colpa. Ma questa liberazione avrà un prezzo elevato: quello di una condanna a vagare senza senso e senza scopo per le strade di Trieste e dell’esistenza.
“Anche il passato cambia”
Ma esisteva per lui una possibilità diversa? Come ha scritto felicemente Aldo Giorgio Gargani, “anche il passato cambia”16: esso, cioè, può assumere significati nuovi e prendere senso all’interno dell’esperienza presente. Ma il passato può cambiare soltanto se lo sguardo che ad esso viene rivolto non è il raggio freddo e scrutatore di un'indagine oggettiva, non è l’apertura di porte segrete e colpevoli, non è lo svelamento di condanne ormai per sempre pronunciate, ma è piuttosto l'avvio di una costruzione di senso, di elaborazione del “presente del passato”, per usare le parole di Sant'Agostino.
La vicenda psicoanalitica, intesa come “relazione profonda tra due esseri umani […] rispettosa dell'anima”17 può essere una via privilegiata per una ricerca di significati dell’esperienza passata all’interno di una relazione: una relazione che fa rivivere e rielabora qui e ora il passato, anziché interrogarlo e frugarlo.18 Ma l’esperienza che Guido Marenzi ha avuto della psicoanalisi è stata ben diversa, e nessuno sembra oggi disposto ad ascoltarlo, a elaborare con lui il senso dei suoi sogni, dei suoi ricordi, delle sue angosce.
"Questi sogni non li racconto a nessuno, li potrei raccontare a Giovanna, ma lei è troppo concreta, sento che non li capirebbe come vorrei".19
Dunque, Guido Marenzi è solo con se stesso: e in effetti tutta la sua giornata è intessuta di monologhi, interrotti solo ogni tanto da frammenti di conversazione, nella quale nessuno ascolta veramente l’altro. E forse, durante questi monologhi, neppure lui è in grado di ascoltare se stesso: troppo grande è il suo carico di angoscia. In questo senso, si potrebbe dire che egli è più vicino al Bloom di Joyce che non allo Zeno di Svevo. La caratteristica peculiare di quest’ultimo, infatti, è una sorta di perenne autoironia che, invece, manca a Guido: un'autoironia che segnala l’esistenza di una relazione interna tra parte narrante e parte che ascolta ed elabora la narrazione. Le associazioni alle quali il protagonista si abbandona (apparentemente libere, senza remore né ritegni, ma più in profondità dominate dal terrore di aprire porte proibite o, alternativamente, dalla compulsione a farlo: proprio come Barbablù) non costituiscono infatti una sorta di autoanalisi, perché in esse manca la relazione essenziale tra espressione e comprensione. Non a caso, l’unica dialettica messa in scena nei pensieri di Guido è quella tra inquisitore ed inquisito.
Tra Barbablù e Leopold Bloom
In particolare, il protagonista sembra non cogliere la possibilità che il senso di colpa dal quale è oppresso possa venire ascoltato anche come un messaggio interiore significativo e vitale: che la colpa sia innanzitutto verso se stesso, verso la propria umanità mutilata da rapporti superficiali e inautentici con gli altri. La difficoltà di aprire il plico misterioso, del quale il protagonista giunge a liberarsi annegandolo nell’acqua, segnala l’impossibilità di elaborare un nucleo problematico che impedisce il perdono e, attraverso di questo, l’accesso ad una vita più autentica.
"Presi il plico con le due mani, tenendolo orizzontale, con atto solenne tesi le braccia mormorando Introibo ad altare Dei. Ero proprio al centro del ponte, reggevo il plico sopra l’acqua tranquilla del canale, che svariava quattro metri più in basso. A destra e a sinistra le file dei lampioni globulari emanavano una ferma luminescenza rosea, dentro il canale due file parallele di barchette giungevano fino all’altro ponte affacciato sul mare, nella luce falsa sembravano tutte grigioazzurre. L’acqua placidamente respirava nell’ora di notte. Allargai un po’ le braccia, il plico cadde di piatto e dopo un tempo sentii il tonfo, poi eccentriche onde si allargarono sulla superficie del canale, movendo appena le barche vicine, e si persero in lontananza. Il campanile alle mie spalle batté le due. Mi sporsi dalla spalletta, mi parve di vedere una macchia chiara che ondeggiando svaniva nel nero".20
Il romanzo si conclude così, con la parodia di un rito religioso (che è anche l’eco della prima pagina dell’Ulisse di Joyce): essa, pur nella sua dimensione grottesca, rimanda dolentemente a quella ricerca di assoluto che spesso traspare nel romanzo, anche attraverso personaggi secondari, come il pittore incontrato all’osteria.
"Ha capito, ha capito adesso? Adesso che Le ho detto come stanno veramente le cose, ha capito perché mi voglio svincolare dal tempo e dallo spazio, perché voglio contemplare l’universo, ma non il nostro piccolo miserabile universo, voglio contemplare quello grande, quello che racchiude tutti gli altri, voglio camminare sulla superficie esterna, non sulla fodera del mantello, voglio vedere la luce".21
La fine del sogno dell'assoluto
Ritroviamo in questo delirio un’eco del sogno di un assoluto razionale raggiungibile forse attraverso la scienza: un sogno che rinvia anche al giovane fisico di Alcune orme sopra la neve. Un sogno dal quale, negli anni che intercorrono tra le vicende ungheresi e l’oggi del romanzo, Guido Marenzi è stato bruscamente risvegliato. A volte, sono invece struggenti ricordi d’infanzia a riportare alla mente un altro assoluto: brandelli di preghiere, immagini di vite semplici eppure piene di grazia, fantasie di paradiso.
"Il recinto è protetto da baluardi altissimi, dentro c’è la felicità, una felicità delicata che bisogna difendere dalle minacce esterne. Queste minacce si precipitano volando con grande stridore da tutti i punti dell’orizzonte infinito. Qui, dentro il recinto, la felicità è assoluta e suprema, ma grandissima è l’angoscia di perdere la felicità. L’idea di una perdita così grande è intollerabile, ecco perché bisogna difendere il recinto dal resto del mondo. Il recinto è il paradiso, nel resto del mondo si svolge la lotta infinita tra il bene e il male".22
Ma se l’assoluto della scienza si è sbriciolato e l’assoluto della trascendenza appare irraggiungibile, forse niente più che un sogno infantile, sembra che a Guido non resti che vagare tra rottami e meschinità quotidiane, ben lungi dalla leggerezza auspicata dal protagonista de L’acrobata.
Fin qui il romanzo, con le sue trecentocinquanta avvincenti pagine. Ma il suo finale rimane aperto. Chissà, dunque, che a Guido non accada di incontrare finalmente l’assoluto negli occhi di una donna, o di un amico, o anche di uno stanco scienziato che lo guarda dallo specchio: nella profondità e nel mistero, insomma, della relazione con gli altri e con se stesso.
Cover: Maurits Cornelis Escher, Vincolo d'unione, aprile 1956 litografia, 253x339 mm.
Note:
1 G.O. Longo, La gerarchia di Ackermann, Jouvence, Milano, 2016. Prima edizione presso Mobydick, Faenza, 1998.
2 G.O. Longo, Di alcune orme sopra la neve, Campanotto, Udine, 1991. Seconda edizione Mobydick, Faenza, 2007.
3 G.O. Longo, L’acrobata, Einaudi, Torino, 1994.
4 G.O. Longo, La gerarchia di Ackermann, cit., p.22.
5 Ibid., pp.289-290.
6 Ibid., pp. 91-92.
7 G.O. Longo, L’acrobata, cit., p. 98.
8 G. Zanarini, Ricerca scientifica e ambiguità: sogni e fantasie di un ricercatore immaginario, Nuova Civiltà delle Macchine, XI, 1 (1993), pp. 63-78.
9 G.O. Longo, Di alcune orme sopra la neve, cit., pp. 119 e 140.
10 Ibid., p. 16.
11 G.O. Longo, L’acrobata, cit., p. 151.
12 G.O. Longo, La Gerarchia di Ackermann, cit., p. 281.
13 Ibid., p. 138.
14 Ibid., p. 277.
15 Ibid., p. 82.
16 A.G. Gargani, "Il testo complesso della natura", in M. Ceruti, L. Preta (a cura di), Che cos'è la conoscenza, Laterza, Bari, 1990.
17 G. Di Chiara, "Psicoanalisi: natura e cultura", Rivista di Psicoanalisi, 31 (1986), p.451.
18 G. Zanarini, "Conoscenza e relazione nella prospettiva psicoanalitica", Introduzione a M. F. R. Kets de Vries e D. Miller, L’organizzazione nevrotica, Cortina, Milano, 1992, pp. 11-28.
19 G.O. Longo, La gerarchia di Ackermann, cit., p. 342.
20 Ibid., p. 352.
21 Ibid., p. 270.
22 Ibid., p. 232.