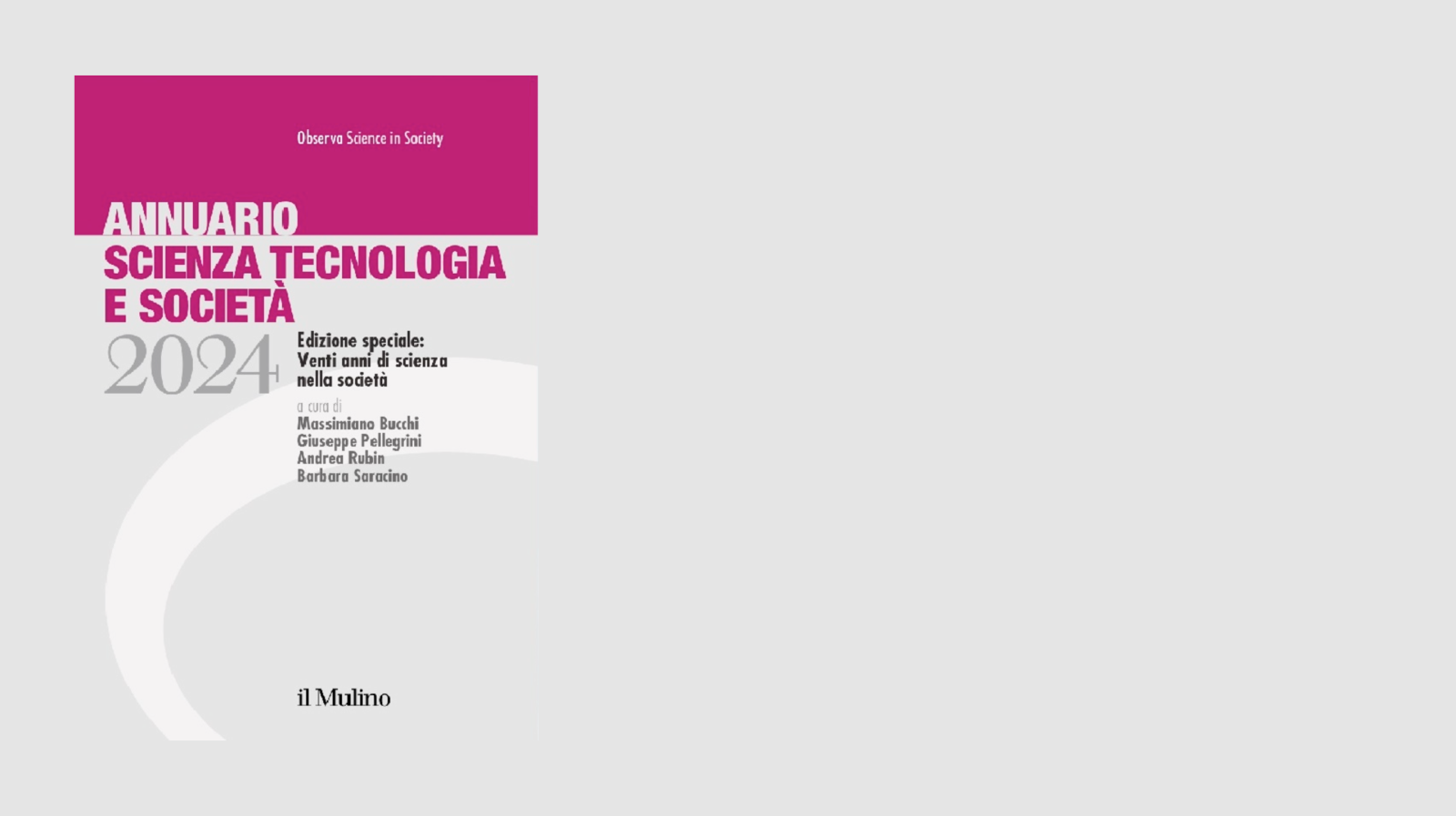Non sarà di me stesso che parlerò, ovviamente, visto che del Nobel conosco solo il profumo: narrerò invece dei vari scienziati, loro sì vincitori di premi Nobel, con cui ho interagito durante oltre mezzo secolo di attività scientifica. Tutti hanno contribuito in modo speciale allo studio e allo sviluppo di quei materiali e dispositivi che hanno rivoluzionato il mondo della microelettronica, dei computer e delle telecomunicazioni, di fatto plasmando il modo di vivere odierno. Sarà questa un’opportunità per richiamare molte delle scoperte che, nel settore della fisica della materia condensata, sono state oggetto di tale onorificenza.
Leo Esaki (1925)
Comincio da Leo Esaki, giapponese, perché fu il primo della serie in cui mi imbattei. Garbato di maniere (ma determinato nelle intenzioni), fu premiato nel 1973 per l’invenzione del diodo tunnel, dispositivo a resistenza negativa, base dei generatori di microonde a semiconduttore, noto anche come diodo di Esaki (divise il premio con Ivar Giaever e Brian Josephson, padre dell’omonimo effetto). Io feci però la conoscenza di Esaki 11 anni prima che ricevesse il Nobel, durante la gita sociale della Conferenza Internazionale di Exeter sulla fisica dei semiconduttori. La gita prevedeva la traversata di parte della baia di Lyme a bordo di un piccolo battello privo di copertura. Poco dopo la partenza, iniziò a diluviare e per tutto il tragitto mia moglie e io ci trovammo addossati a Leo, un po’ per caso e un po’ per cercare di bagnarci il meno possibile. Sbarcammo intrisi d’acqua e di malumore, dopo una navigazione che ci parve un’eternità: mai thè bollente fu più apprezzato di quello che bevemmo appena messo piede a terra. Quando ci separammo da lui, spiegai a mia moglie che il nostro compagno di disavventura era autore di un’importante scoperta - il diodo tunnel, appunto - la quale prima o poi gli sarebbe valsa il Nobel.
Esaki lavorava presso i laboratori dell’IBM di Yorktown Heights (New York), ma tornava ogni tanto in Giappone, fino a fare la spola tra i due paesi dopo che, nel 1992, fu nominato presidente della nuova Università Tsukuba, non lontano da Tokyo. Sovente transitava da Roma, dove l’IBM-Italia lo ospitava come un re nel più lussuoso albergo della città; in alcune occasioni venne a cena a casa mia per fare grandi assaggi di formaggio - cibo assente dal Giappone - e laute bevute di vino rosso. Ricordo che una volta, a notte inoltrata, se ne stava ancora seduto in poltrona a gustare una mistura di gorgonzola e mascarpone, innaffiandola di chianti. Non si decideva a congedarsi, tanto che alle 2 dovetti sollevarlo di peso e trasportarlo in albergo prima che mi si addormentasse nella poltrona.
Leo Esaki parlava un inglese indecifrabile, che solo chi lo frequentava da tempo poteva intendere. «Un Nobel che nessuno riesce a capire» mormoravano alcuni maligni colleghi inglesi, senza precisare se si riferissero alla lingua o ai risultati scientifici, o magari a tutte e due le cose. Fu uno dei conferenzieri a Roma in occasione del cinquantenario della fondazione dell’Istituto di Acustica Orso Maria Corbino del CNR. Le sessioni scientifiche si tennero all’Accademia dei Lincei, dove veniva fornita la traduzione simultanea in cuffia. Alla fine dell’intervento chiesi all’interprete se con Esaki avesse incontrato delle difficoltà. «Per carità» mi rispose. «Ho dovuto inventarmi quasi tutto, di quello che lui diceva afferravo soltanto una parola qui e una là». «Brava davvero» la lodai. «Deve aver fatto un lavoro eccellente, visto che nel pubblico non ho notato particolari segni di sconcerto». Concludemmo che gli uditori dovevano aver trascorso il tempo a pensare ai fatti propri o a dormire a occhi aperti. Spesso i più grandi scienziati, per una ragione o per l’altra, sono i peggiori oratori, e anche dei pessimi didatti. Uno per tutti, il grande Bardeen, come potei verificare seguendo il suo corso avanzato di Fisica dei solidi durante la mia permanenza all’Università dell’Illinois.

Leo Esaki a Roma nel 1987, in occasione del cinquantenario dell’Istituto di Acustica Orso Maria Corbino del CNR. Con lui è Benoit Mandelbrot, pioniere dei frattali
Leo Esaki si trovò malauguratamente coinvolto in una tipica vicenda italiana. Verso la fine degli anni ‘70, io e Florestano Evangelisti, allora giovane assistente, sottoponemmo al CNR un progetto di misura dell’effetto Hall quantizzato nei semiconduttori (vedi più avanti). Parte del lavoro si sarebbe dovuto svolgere nel nostro laboratorio e parte in quello di Esaki all’IBM, specificamente la sofisticata preparazione delle strutture quantiche. Costo previsto per il magnete superconduttore da allestire a Roma, 60 milioni delle vecchie lire. Il progetto fu approvato, manco a dirlo, ma la somma stanziata fu di soli 6 milioni. Fummo costretti a lasciar cadere l’idea. Alcuni anni dopo un esperimento simile a quello da noi progettato fruttò il Nobel a Klaus von Klitzing. Ma devo francamente ammettere che, pur con l’aiuto di Esaki, le carenze dell’ambiente universitario italiano difficilmente ci avrebbero permesso di battere Klaus sul tempo.
Ho conosciuto e frequentato entrambe le mogli di Leo. La prima, quando lui era ancora un fisico normale, benché già vincitore di svariati premi, si chiamava Masako: di grande intelligenza, formava con lui una coppia perfettamente assortita. Nondimeno, diversi anni dopo il conseguimento del Nobel, si separarono. Leo si risposò quasi subito con un’altra giapponese, anche lei di nome Masako, ma bella, ricca, molto raffinata, una pittrice che gli riempì di grandi quadri la casa di Yorktown Heights. Una volta che con mia moglie mi trovavo di passaggio da quelle parti ci invitò a cena per farci conoscere la nuova sposa e ammirare le sue opere. Potere del premio Nobel, pensammo, trasforma in oro tutto quello che tocca.
John Bardeen (1908-1991)
È l’unica persona ad aver vinto due volte il premio Nobel per la stessa disciplina, nel 1956 per l’invenzione del transistor quand’era ai Laboratori della Bell Telephone (assieme a William Shockley e a Walter Brattain), e poi nel 1972, divenuto professore presso l’Università dell’Illinois a Urbana, per la teoria della superconduttività nei metalli, assieme a Leon Cooper e a Robert Schrieffer (teoria BCS). Bardeen fu il mio capo-laboratorio durante i due anni (1963-65) che trascorsi come ricercatore in quell’università. Era uno scienziato in cui capacità e modestia si fondevano mirabilmente, un uomo in cui saggezza e semplicità aprivano facili vie di interazione con gli altri, fossero anche semplici tecnici o studenti. Lo chiamavano whispering John, ossia “John sussurrante”, definizione perfetta del suo modo di essere e di proporsi.
Il primo incontro con lui avvenne subito dopo il mio arrivo a Urbana, e fu quanto di più inaspettato un timido borsista appena sbarcato in terra americana potesse immaginare. Il capo mi invitò subito a pranzo presso il suo country club. Appuntamento alle 19, ora di cena in USA. Pieni di zelo, mia moglie e io consultiamo mappe cittadine fin dal pomeriggio, individuiamo il golf club, e ci mettiamo in moto con un buon anticipo. Sorpresa, al country club di Urbana non v’è traccia di Bardeen, né il nome suona familiare agli uscieri. Aspettiamo tre quarti d’ora, guardati come dei minus habens che hanno fatto confusione con l’inglese. Poi il lampo: ma sì, Urbana e Champaign, le città gemelle tra le quali sono distribuite le dimore degli universitari. La sede dell’Ateneo è a Urbana, ma i Bardeen evidentemente abitano a Champaign e frequentano il locale golf club. Sudiamo freddo. Altro esame di mappe, altra corsa in macchina verso la nuova destinazione. Arriviamo alle otto. Sulla porta del club, ad attenderci con il più incoraggiante dei sorrisi, ci sono John Bardeen e la moglie. Nessuna domanda, nessun segno di impazienza, massima cordialità. Purtroppo alla prima gaffe ne feci seguire subito un’altra, ordinando un papa filet in luogo del normale filet mignon, avendo supposto che il secondo fosse a uso dei bambini. Invece mi arrivò un filetto da mezzo chilo, con un corrispondente quantitativo di patate. Una dose per tre. Italiani morti di fame, avrebbe pensato chiunque altro che non fossero i Bardeen, i quali invece neanche diedero mostra di accorgersi della mia goffaggine. Persone da cui ci sarà molto da imparare, pensai.

L’unica foto in mio possesso di John Bardeen (al centro), scattata quando nel 1990 passai a visitarlo all’Università dell’Illinois. A destra il suo vice Paul Handler, a sinistra lo scrivente. Bardeen morì l’anno seguente
William Shockley (1910-1989)
In tempi diversi ho avuto contatti anche con gli altri scienziati che divisero il Nobel con Bardeen. I co-inventori del transistor, Brattain e Shockley, li ritrovai consulenti dei laboratori della Bell Telephone a Murray Hill nel New Jersey (Bell Labs) quando nel 1965 vi fui assunto come ricercatore. Shockley, benché dotato di un’intelligenza acutissima, scrisse una volta che i test di intelligenza degli americani “neri” davano in media punteggi inferiori a quelli dei “bianchi”, e questi a loro volta inferiori a quelli dei “gialli”. Si fece anche promotore della banca dello sperma “di alta qualità” dal nome “Repository for Germinal Choice”, di cui fu tra i primi donatori. Tacciato di razzismo, fu bandito dalla cerchia degli scienziati rispettabili e negli anni a seguire completamente ignorato dagli stessi Bell Labs, a cominciare dal raduno dei tanti premi Nobel che lì avevano militato, a cui io e Mario Capizzi, di passaggio nella zona di Murray Hill, fummo cortesemente invitati, ma dal quale Shockley fu deliberatamente escluso. Figuriamoci: come ammetterlo, anche se premio Nobel, a una tal celebrazione presso i Bell Labs, istituzione che si fregiava della scritta equal opportunity employer!
Mi sembra doveroso spendere due parole in più sul caso Shockley. Ciò che egli fece dopo il Nobel, prima mossa di una linea di ricerca nel settore sociale - razza, intelletto ed eugenetica - fu di confrontare la media dei QI (indici di intelligenza) raccolti in tre scuole di San Francisco, la prima in un quartiere interamente bianco, variamente frequentato, la seconda in una zona di neri e la terza nell’area di Chinatown, frequentata interamente da cinesi di classe medio-alta, commercianti, funzionari, impiegati. Un esperimento avviato, per così dire, in modo “scientifico”. Date le assai diverse condizioni economiche, ambientali e sociali delle tre scuole, il QI medio dei cinesi emerse al primo posto, quello dei bianchi secondo e ultimo quello dei neri, risultanza del tutto scontata.
Shockley commise l’imprudenza di scriverlo sui giornali e parlarne in conferenze, dando forse per scontato che lui, uomo di grande intelligenza e cultura, premio Nobel, sarebbe stato giudicato sui fatti e mai sospettato incline ai pregiudizi razziali. Debbo dire che quando me ne parlò mi convinse di essere, più che razzista, una persona molto preoccupata della poca chiarezza e grande superficialità con cui veniva trattata la tematica. Il fatto è che, una volta etichettato come razzista e messo in un angolo dalla maggioranza dei colleghi, si spostò sempre più nella direzione peggiore, arrivando a fare affermazioni pubbliche del tipo: «Le mie ricerche mi portano inevitabilmente all’idea che la causa principale dei deficit intellettivi e sociali dei neri americani è ereditaria e di origine genetica razziale e quindi non rimediabile in misura maggiore da miglioramenti pratici nell’ambiente»; e anche «Un tasso di riproduzione più alto tra le persone meno intelligenti porterebbe a un effetto disgenico, implicante un calo dell’intelligenza media e un declino della civilizzazione». Il suo principale errore fu, a questo punto, quello di fondare la banca dello sperma di cui ho già parlato sopra, una prova inequivocabile della sua fede nell’ereditarietà genetica.
Robert Schrieffer (1931-2019)
Quanto ai colleghi del Nobel 1972 per la superconduttività, Schrieffer e Cooper, già allievi di Bardeen e poi divenuti anch’essi docenti a Urbana, ho interagito con il primo perché nel lontano 1957 aveva pubblicato una teoria sulle proprietà di superficie dei semiconduttori che aveva ispirato al mio relatore Gianfranco Chiarotti l’argomento assegnatomi come tesi di laurea a Pavia. Mi duole pensare che nel 2004 Schrieffer sia finito in un carcere californiano per aver falciato una famiglia mentre guidava ben oltre i limiti di velocità senza patente, ritiratagli per precedenti infrazioni stradali. Nella sentenza emessa dai giudici veniva detto esplicitamente che il suo essere premio Nobel costituiva un’aggravante.
Sir Nevill Mott (1905-1996)
Un indimenticabile personaggio fu l’inglese Nevill Mott, premio Nobel nel 1977 con Phil Anderson, statunitense, per una vasta gamma di studi fondamentali, in particolare sulla localizzazione dei portatori di carica e sulle transizioni metallo-isolante. Con loro, fu premiato anche John van Vleck, pure statunitense, per importanti lavori sul magnetismo. A Mott, in occasione del suo ottantesimo compleanno, allorché si trovava a Roma per la Conferenza internazionale sui semiconduttori amorfi nel 1985, fu conferita dall’Università La Sapienza una laurea honoris causa. Dopo aver sostenuto una battaglia con il collega latinista che aveva tracciato la motivazione inventandosi cervellotiche parole latine per tradurre i termini scientifici, ebbi l’onore di recitare il discorso elogiativo. Mott comparve di fronte alla commissione con una vecchia valigetta di cartone, forse un giocattolo conservato dall’infanzia. La valigetta pensò bene di spalancarsi all’improvviso rovesciando al suolo fogli e oggetti personali, che Mott, reso ancora più austero dalla maestosa toga che si indossa in tali circostanze, raccolse a uno a uno. Volle pronunciare il suo ringraziamento in italiano, lingua che aveva studiato solo negli ultimi due mesi (io gli corressi il testo, ma non potei fare niente sulla pronuncia). Fu per lui una gran faticata, per noi un autentico spasso, ma anche e soprattutto una lezione di stile. Dichiarò che ciò che più lo inorgogliva era che 27 anni prima l’Università di Roma aveva attribuito la laurea honoris causa al grande poeta inglese T.S. Eliot, di cui ci lesse alcuni versi, di sapore vagamente scientifico, sulla conoscenza del mondo in cui viviamo.
Tra i tanti ricordi che testimoniavano i suoi legami con l’Italia, in privato me ne riferì uno alquanto spassoso. Quando, appena ventiseienne, giunse a Roma per il mitico Congresso Solvay del 1931 - un congresso presenziato da tutti i geni della fisica all’epoca viventi - fu accolto alla stazione ferroviaria da alcune autorità con fascia tricolore e banda musicale. Rimase paralizzato dalla sorpresa finché, guardandosi alle spalle, si rese conto che dallo stesso treno era sceso un grosso personaggio politico del regime fascista. Durante la memorabile cena a Palazzo Barberini che seguì la cerimonia di laurea honoris causa ebbe modo di incontrare Edoardo Amaldi, che aveva fatto la sua conoscenza in quella remota occasione e che gli era succeduto, molti anni dopo, nella presidenza della IUPAP (International Union for Pure and Applied Physics).
La distrazione di Nevill Mott era proverbiale. Sulla sua figura nacquero una serie di gustose storielle, messe in giro dai suoi affezionati allievi. In quei giorni ne circolava una veramente tremenda, che riferisco in poche parole. Mott rientra a casa dopo un’intensa giornata di lavoro, ma giunto nei suoi paraggi non si ricorda quale particolare villetta sia la sua. Allora si rivolge a una bambina che sta giocando a palla sul prato e le chiede: «Per cortesia, piccina, sapresti dirmi dove abita il professor Mott?». E la bimba, indicando la porta alle sue spalle: «Qui, papà!».

Sir Nevill Mott incontra il Rettore Antonio Ruberti (in seguito ministro dell’Università e della Ricerca) prima del conferimento della laurea honoris causa all’Università di Roma La Sapienza, anno 1985. Sul retro Marini Bettolo Carlo Di Castro
Nevill Mott ritornò al suo orticello in quel di Cambridge - al quale si dedicava da quando era andato in pensione - portando con sé una cravatta della Sapienza che Giorgio Salvini (in seguito presidente dell’Accademia dei Lincei e ministro) volle personalmente annodargli al collo durante una festicciola a casa mia.
Phil Anderson (1923-2020)
Quanto a Phil Anderson, che era consigliere speciale del presidente dei Bell Labs, qualche anno prima del Nobel, nel 1977, mi aveva ceduto il suo lussuoso ufficio allorché, successivamente al mio rientro in Italia, fui ospite dei laboratori per un semestre. Lui era all’Università di Oxford, dove insegnava per metà dell’anno. Ai Bell Labs, nemmeno cotanto personaggio poteva permettersi di lasciare il suo ufficio inutilizzato. Fu una grande esperienza frugare, autorizzato, tra i suoi libri e i suoi importanti documenti. Qualcosa di simile accadde, durante un altro mio soggiorno presso i Bell Labs, con Arno Penzias, premio Nobel nel 1978 insieme a Robert Wilson per la scoperta della radiazione di fondo cosmico (il russo Piotr Kapitza condivise il premio per le sue ricerche nella fisica delle basse temperature). Tale scoperta è la più importante delle prove sperimentali a favore delle teorie cosmologiche che prevedono il Big Bang. In sua assenza, mi avvalsi del suo tecnico e delle sue apparecchiature, facendo naturalmente della spettroscopia dei materiali e non dei corpi celesti, dato che l’astrofisica non rientra nelle mie competenze.
Un’ultima curiosità su Phil Anderson, che mi è stata rammentata da Mario Capizzi, mio successore presso i Bell Labs: egli minacciò di interrompere il suo rapporto con i laboratori quando questi ventilarono il licenziamento del teorico Eugene I. Blount per scarsa produttività. Blount era lento e meticolosamente accurato, ma era persona di grande valore e di profonda cultura scientifica, su cui molti ricercatori facevano affidamento, a cominciare da Anderson stesso. Naturalmente i Bell Labs scelsero di fare una rapida marcia indietro.
Klaus von Klitzing (1943)
Aristocratico tedesco, come dice il von, vinse il premio Nobel nel 1985 per l’effetto Hall quantizzato (regolare): in certe condizioni, la resistenza offerta dai semiconduttori al passaggio della corrente elettrica in presenza di un campo magnetico gradualmente crescente risulta quantizzata, varia cioè per salti discreti e non in maniera continua.

Klaus von Klitzing a Roma nel 1987 per il cinquantenario dell’Istituto di Acustica Orso Maria Corbino del CNR
Anche Klaus è passato spesso da Roma e di lui voglio ricordare che era alquanto fiero di aver potuto comprare, con i quattrini del Nobel (sul milione di dollari del tempo, mi pare, milione che, fatto rarissimo, non dovette spartire con nessun co-vincitore) la villa di un celebre calciatore, se non erro Beckenbauer. Si sarebbe quasi detto che per lui questa insolita circostanza contasse più dello stesso premio.
Alex Müller (1927)
Altro personaggio che la nostra facoltà di scienze alla Sapienza volle onorare con una laurea honoris causa è lo svizzero Alex Müller, scopritore della superconduttività ad alta temperatura negli ossidi perovskitici (insieme a J. Georg Bednorz, anno 1987). Del mio braccio destro Mario Capizzi, che vent’anni prima, come vincitore di una borsa a Zurigo, aveva collaborato con lui appunto sulle perovskiti, soleva ribadire: «Mario è un giovane molto devotato alla ricerca». Anche a Müller piaceva parlare in italiano, e bisogna dire che, “devotato” a parte, se la cavava infinitamente meglio di Mott!

Università di Roma La Sapienza, anno 2000. La commissione per la laurea honoris causa ad Alex Müller, quarto da sinistra, scopritore della superconduttività ad alta temperatura. Dei fisici si riconoscono lo scrivente, Carlo di Castro (che lesse l’elogio), Luciano Pietronero, Mario Capizzi, Gianni Jona Lasinio
Horst Störmer (1949)
Premio Nobel nel 1998 con Robert Laughlin, statunitense, e Daniel Tsui, sino-americano, per aver scoperto e spiegato l’effetto Hall quantizzato frazionario (rinuncio a tentarne una descrizione elementare!). La vita di Horst si intreccia con la mia in varie maniere. Riferirò solo qualche episodio. Tedesco di qualità, bello e cordiale, semplice e soft-spoken, dopo aver conseguito la laurea in Germania e aver lavorato per qualche tempo al grande laboratorio europeo dei magneti di Grenoble (dove ebbi modo di conoscerlo, essendo io a quel tempo già rientrato dagli USA e trovandomi temporaneamente ospite della vicina Losanna), alla fine degli anni ‘70 fu assunto dai Bell Labs. Portava i capelli lunghi alla Gesù Cristo e conviveva con una donna separata. Scaduto il periodo contemplato dal suo visto temporaneo (exchange visa), risolse di fermarsi negli USA, anche perché la sua compagna era impiegata all’ONU. Questo era possibile soltanto se il visto veniva commutato in un permesso di soggiorno permanente (green card) - come era successo in precedenza per me e per altri - operazione che richiedeva una speciale deroga alle leggi vigenti da parte del Dipartimento di stato (l’influenza dei Bell Labs sul governo era tale che ciò si riduceva a una pura formalità). Il procedimento questa volta fu però bloccato da un tassativo veto, posto forse da qualche alto dirigente molto puritano. Molti di noi avevano intuito che Horst era vicino a grandi scoperte, ma che solo restando ai Bell Labs avrebbe raggiunto i suoi obiettivi in tempi brevi. Partì allora in suo sostegno una formidabile campagna internazionale, promossa a Stoccarda da Manuel Cardona, della quale, da Roma, fui compartecipe. Su di lui vennero scritte lettere entusiastiche, tanto che alla fine Horst vinse la battaglia. Soltanto anni più tardi, però - forse nei pressi del Nobel - egli si risolse a tagliarsi la chioma e a sposare la sua compagna.
Un altro episodio riguarda la caduta del muro di Berlino. Il 10 novembre 1989 mi trovavo di passaggio alla stazione di Venezia diretto al Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (ICTP). Da buon veneziano non mancavo mai di spezzare il viaggio Roma-Trieste per una corsa in vaporetto lungo il Canal Grande. Ebbene, quel giorno anche Störmer fece la stessa cosa, tanto che ci trovammo insieme ai piedi del treno. I giornali nelle edicole recavano in grande evidenza la notizia che la sera precedente erano stati aperti tutti i varchi nel muro di Berlino e che i cittadini dell’Est potevano liberamente sconfinare a Ovest. Ci abbracciammo: poche volte il gesto fu più naturale e sentito. Con Horst e la sua compagna, abbiamo passato deliziose serate, oltre che a Roma, a Trieste e a New York, e anche in Sardegna, a Grenoble, a Kyoto, a Praga, a Washington, in California, e non so in quanti altri posti di questo piccolo pianeta su cui i fisici si muovono continuando a incrociarsi.

Horst Störmer a Roma nel 1976 durante la tredicesima Conferenza internazionale sulla fisica dei semiconduttori
Mi piace fare un confronto tra i due Nobel tedeschi legati all’effetto Hall quantizzato, cioè Klaus von Klitzing (quantizzazione intera) e Horst Störmer (quantizzazione frazionaria). Tanto magniloquente il primo nelle sue pubbliche presentazioni, e simpaticamente esuberante, quanto sobrio, pacato e splendidamente persuasivo il secondo, vero maestro dell’understatement. Con aspri accenti tedeschi l’inglese del primo, scorrevole e morbido quello del secondo. Mario Capizzi mi ha ricordato di una volta a Osaka - era l’anno 2000 - in cui il destino volle che Klaus fosse il più autorevole degli speaker in una sessione in cui Horst fungeva da chairman. Mentre Klaus decantava con voce stentorea i fascinosi aspetti della quantizzazione nelle superstrutture a semiconduttore - fascinosi indubbiamente, non meno di un canone bachiano, almeno per noi fisici - Horst dava mostra di sbuffare, dondolando lentamente il capo da destra a sinistra. Un veloce scambio di parole tra Mario e Horst, a sessione conclusa, confermò la comune sensazione che, come suo solito, Klaus sembrava essersi dimenticato di parlare a una platea di esperti che, a 15 anni dal suo Nobel, erano ormai piuttosto bene informati sull’argomento.
Zhorès Alferov (1930-2019)
Ed ecco una figura veramente unica, il russo Zhorès Alferov, che ricevette il Nobel insieme a Herbert Kroemer e Jack Kilby nel 2000 per lo sviluppo delle eterostrutture usate nell’elettronica veloce e nell’optoelettronica, ossia LED e laser a semiconduttore, i dispositivi base della trasmissione su fascio di luce. Direttore del grande Istituto Yoffe a San Pietroburgo, consigliere personale di Gorbaciov, figura di spicco nell’Accademia delle Scienze dell’URSS, più tardi membro del Parlamento del popolo, nato con la perestroika. Figlio orgoglioso di un protagonista della rivoluzione sovietica, Zhorès era tanto ruspante di maniere quanto fine di cervello. Negli anni ‘80, a Roma, lo condussi a un concerto dell’Accademia di Santa Cecilia. Benché apprezzasse la musica, per tutto il tempo continuò a schiarirsi la gola e a fare commenti ad alta voce, superando in rumorosità persino il già maleducato pubblico romano. Avrei voluto sprofondare.
Nel 1989, perestroika ancora agli inizi, mi trovavo con mia moglie a San Pietroburgo. Zhorès ci invitò a pranzo nella sua dacia di Komarova presso la costa del Baltico, a un’ora di macchina dalla città. Mandò a prenderci in albergo la lussuosa Volga nera di servizio che era a sua disposizione. Sfrecciammo attraverso villaggi e snodi stradali senza mai scendere sotto i cento all’ora. Quando, in pieno abitato, transitammo davanti a una pattuglia della polizia, cominciammo a temere il peggio. Ma tutto filò liscio. «Nessuno oserebbe fermare questa vettura» disse l’autista con fierezza. «La nostra targa è sacra» . Nella sua dacia, circondata da altre villette di eminenti personaggi della scienza e della cultura - pochi erano i non-politici che avevano goduto del privilegio di una seconda casa durante il regime sovietico - brindammo a un suo futuro premio Nobel: un augurio un po’ azzardato, pensai, ma che si sarebbe avverato, puntualmente, 11 anni più tardi. Nel pomeriggio Zhorès volle condurci al piccolo cimitero dove, tra grandi scienziati e artisti, riposa Anna Achmatova, poetessa russa perseguitata dal regime sovietico e il cui marito, Nikolàj Gumilëv, subì la fucilazione. E sulla sua tomba, pur rustico com’era, Zhorès si commosse come le anime più semplici.

Un brindisi nella dacia di Zhorès Alferov (capotavola) nel 1989
Uno dei più bei concetti espressi da Zhorès quando ci è capitato di discutere di politica, di perestroika e di annessi vari, è stato che il socialismo, se pure ha fallito nell’Est europeo, ha prodotto grandi benefici nei paesi capitalisti. Un’affermazione paradossale? No: se non fosse esistita la filosofia marxista, se non si fosse tentato di metterla in pratica nei paesi del socialismo reale, i lavoratori in occidente non avrebbero conseguito le condizioni di emancipazione dallo sfruttamento di cui invece oggi si trovano a godere. Alferov parla con una certa cognizione di causa: egli è stato infatti uno dei rarissimi scienziati russi che, durante il regime sovietico, è riuscito a trascorrere un periodo di perfezionamento negli Stati Uniti, proprio in quei Bell Labs dove diversi tra noi italiani si sono fatte le ossa. Non credo di sbagliare ricordando che lì, sotto la guida di Morton Panish, egli apprese quella raffinata tecnica epitassiale per la crescita delle superstrutture che avrebbe importato nell’Istituto Yoffe e che, alla lunga, gli avrebbe permesso di inserirsi nella rosa dei premi Nobel su questo tema, sorpassando grandi operatori del settore, come Panish stesso, Arthur Gossard, Alfred Cho, Raymond Dingle ai Bell Labs, e Leroy Chang, Ray Tsu e di nuovo Leo Esaki ai laboratori IBM (e altri ancora che per brevità evito di elencare).
Willard (Bill) Boyle (1924-2011) e George Smith (1930)
Gradevole è il ricordo di questi due colleghi, premi Nobel nel 2009, rispettivamente direttore del laboratorio in cui lavoravo ai Bell Labs negli anni 1965-67 e capo del sottogruppo in cui mi ero inserito. Ero stato assunto per la notorietà acquisita dalla tecnica di spettroscopia modulatoria che avevo sviluppato a Urbana presso l’Università dell’Illinois partendo da idee nate a Pavia al tempo della tesi svolta sotto la guida di Gianfranco Chiarotti. A Urbana il direttore era, come già detto, John Bardeen, il suo vice Paul Handler. Il mio compito era quello di approfondire le proprietà di superficie dei semiconduttori sia a scopi conoscitivi sia in vista di possibili applicazioni.
Come già verificato nel FET (Field Effect Transistor), le proprietà di trasporto della corrente elettrica in questi materiali può essere alterata applicando, tramite un elettrodo parallelo alla barretta di semiconduttore, un campo elettrico normale alla superficie. Bardeen prevedeva che dispositivi basati su tale proprietà - l’effetto campo - si prestassero a straordinarie applicazioni. Fu per questo che mi diede un posto di ricercatore nel suo laboratorio. E fu forse per questo stesso motivo che, più tardi, Willard Boyle e George Smith dei Bell Labs si accorsero di me e mi offrirono un ruolo permanente ai Bell Labs.
E qui feci uno dei più grossi errori della mia vita. Mi lasciai sedurre da Dawon Kahng, fisico coreano, inventore dell’importante dispositivo noto come MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor). Kahng aveva avviato degli esperimenti con le perovskiti ferroelettriche che a me erano parsi suggestivi e forieri di importanti risultati. Fatto sta che entrai sì nel laboratorio Smith-Boyle, ma per fare ricerca sulle perovskiti di Kahng e non sul dispositivo di tipo MOS su cui trafficavano George Smith e Bill Boyle. I due, un paio di stanze più in là della mia, stavano mettendo a punto il CCD (Charge-Coupled Device), primo sensore microscopico di immagine, capace di tradurre un volto o uno scenario in una serie di segnali elettrici da trasmettere a grande distanza. Si affidava, oltre all’effetto fotoelettrico di eisteiniana memoria, all’effetto campo applicato da Kahng nel MOSFET e alle mie esperienze di laurea in quel di Pavia. Oggi il CCD rappresenta l’occhio digitale universale di fotocamere, videocamere e rilevatori di immagine.
Qui mi si conceda di fare un salto di quasi mezzo secolo avanti. Nel 2009, durante una cena a San Diego in un magnifico ristorante cinese con moglie e amici vari, Chen Yen-Sun, negli anni 1965-67 membro del mio stesso gruppo presso i Bell Labs e perfettamente al corrente di tutte le vicende connesse alla nascita del CCD, mi chiese: «Ma tu, che pensi del fatto che a Bill e George non sia stato ancora dato il Premio Nobel?». «Caro Bill» risposi, usando il soprannome che gli americani, per comodità, gli avevano affibbiato, «sai bene quante brighe ci sono dietro all’assegnazione di un Nobel! Basta che si rendano conto di quanto vasto può essere l’impiego del CCD e ai nostri due boss il premio arriverà. Ora lo usano tantissimo anche gli astrofisici nella fotografia spaziale, e gli astrofisici, si sa, contano assai! Il premio arriverà».
L’indomani salimmo a bordo di un aereo per rientrare in Italia, dove una delle prime cose che apprendemmo fu che il giorno prima era stato assegnato il Nobel 2009 per la fisica agli inventori del CCD, Boyle e Smith. Straordinaria coincidenza di tempi e di intenzioni! Il titolo del comunicato stampa era Masters of Light (Signori della luce). Vi si raccontava che i due Nobel erano stati in grado di imbrigliare la luce, farla viaggiare per centinaia di chilometri e poi raccoglierla, trasformarla in segnale elettrico e ricostruire con essa delle immagini (merita notare la consueta imprecisione giornalistica!). Pensai: peccato per Dawon Kahng, che forse al tempo era stato l’ideatore del progetto: nel frattempo era deceduto e, si sa, il Nobel non si assegna ai defunti. E peccato per me stesso cui era stata offerta la possibilità di essere coinvolto nel lavoro, dato che avevo proprio le necessarie competenze! Ma, come ho detto, in quell’occasione feci la scelta sbagliata!

Willard Boyle e George Smith
Gli altri
Diversi altri premi Nobel sono andati al settore di ricerca della fisica della materia condensata negli ultimi decenni, ma i vincitori sono persone con cui non ho avuto dirette connessioni. Citerò i principali in ordine cronologico: nel 1952 gli statunitensi Felix Bloch e Edward Purcell, per misure di precisione e scoperte riguardanti la risonanza magnetica nucleare; nel 1961 Ludwig Mössbauer, tedesco, per la scoperta dell’omonimo celebre effetto (insieme a Robert Hofstadter, statunitense, per lo studio della struttura dei nucleoni); nel 1970 Hannes Alfvén, svedese, e Louis Néel, francese, per lavori fondamentali rispettivamente nella flouidodinamica e nel ferromagnetismo; nel 1981 Kai Siegbahn, svedese, per i suoi contributi alla spettroscopia fotoelettronica in alta risoluzione, assieme a Nicolas Bloembergen e Arthur Shawlow per lo sviluppo della spettroscopia laser; Gerd Binnig e Heinrich Rohrer (1986, tedeschi), per l’invenzione della spettroscopia a scansione per effetto tunnel, unitamente a Ernst Ruska, anch’egli tedesco, per lo sviluppo della microscopia elettronica; Pierre-Gilles De Gennes (1991, francese) per importanti studi in molti campi fra cui i superconduttori, i cristalli liquidi e i polimeri; nel 1994 Bertram Brockhouse, canadese, e Clifford Shull, statunitense, per lo sviluppo delle tecniche di diffrazione dei neutroni nello studio della materia; nel 1996 i tre statunitensi David Lee, Douglas Osheroff e Robert Richardson per la scoperta della superfuidità dell’elio-3; Claude Cohen-Tannoudji (1997, francese), con gli statunitensi Steven Chu e William Phillips, per aver introdotto il raffreddamento e l’intrappolamento di atomi per mezzo della luce; nel 2003 Alexei Abrikosov, Vitaly Ginsburg (russi) e Anthony Leggett (britannico) per contributi basilari alla teoria dei superconduttori e dei superfluidi; e infine nel 2007 Albert Fert, francese, e Peter Grünberg, tedesco, per le ricerche e le applicazioni della magnetoresistenza gigante (GMR), che ha permesso di superare la barriera dei gigabyte nelle memorie dei computer e di tanti altri dispositivi.
Abdus Salam (1926-1996)
Citerò anche, benché appartenente a un altro ramo della fisica, quella delle alte energie, il pakistano Abdus Salam, premio Nobel nel 1979 con Steven Weinberg e Sheldon Lee Glashow per la teoria sull’unificazione delle energie elettromagnetica e nucleare debole. Negli anni ‘80-’90 mi recavo periodicamente al Centro ICTP di Trieste per organizzare dei simposi sulla fisica dei semiconduttori: come direttore, Salam mi diede sempre un valido appoggio, grazie anche alla collaborazione di Erio Tosatti. Sotto la sua direzione (dalla fondazione nel 1964 a tutto il 1993), l’istituto divenne rapidamente uno dei centri più importanti della comunità scientifica internazionale. Un particolare raro tra gli scienziati che operano in Occidente: da musulmano, si poteva concedere di avere due famiglie, una residente a Trieste, l’altra a Londra. Nessuna unificazione, in questo settore.

Simposio internazionale sui semiconduttori a Trieste, anno 1982. Da sinistra: lo scrivente, Abdus Salam, Robert Bauer, Erio Tosatti
Giorgio Parisi
E veniamo all’ultimo premio, quello che tocca l’Italia più da vicino, il Nobel a Giorgio Parisi, mio collega nel Dipartimento di Fisica di Roma La Sapienza.

Giogio Parisi
Credo, o almeno mi illudo, di essere stato il primo a istruire l’iter formale tanti tanti anni fa - a nome anche di importanti colleghi non italiani - dopo la pubblicazione dei suoi lavori sui vetri di spin degli anni 1979-80. Altri tentativi furono fatti negli anni a seguire, senza successo, ma col risultato di farmi divenire un esperto dei meccanismi che regolano questo grande riconoscimento. Nel 2021, finalmente, il premio è arrivato! Motivazione: «per la scoperta dell’interazione fra disordine e fluttuazioni in sistemi fisici, da scale atomiche a scale planetarie». In questa mia iniziativa, fui grandemente incoraggiato dall’enorme stima che Giorgio Salvini - ex-presidente dell’Accademia dei Lincei ed ex-ministro della Ricerca e dell’Università - aveva espresso nei confronti di Parisi sin da quando nel 1967 ero rientrato in Italia dagli USA. Giorgio allora era ancora studente, laureando di Nicola Cabibbo, ma stava per esplodere con le teorie che, culminando nei voli di storni, noti anche al vasto pubblico, lo hanno consacrato agli altari della patria. Un buon articolo che illustra in dettaglio l’attività scientifica di Parisi, come io, da fisico sperimentale, non saprei fare, è stato scritto da Enzo Marinari per Scienza in rete.