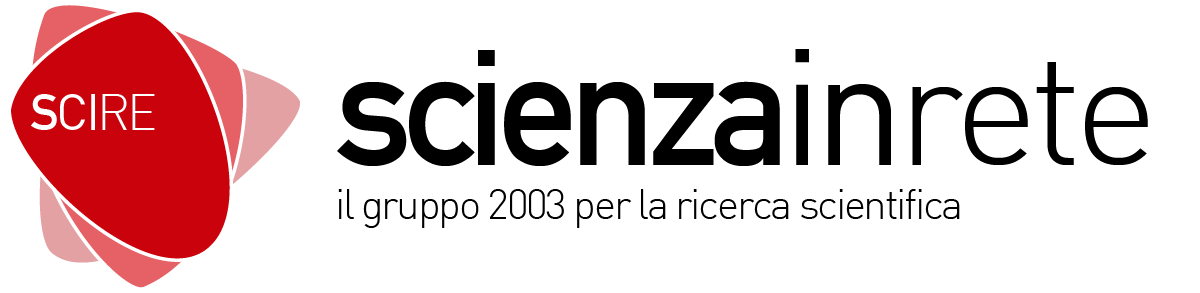Le grandi riviste scientifiche e il mondo accademico stanno cominciando a reagire agli attacchi della nuova amministrazione Trump, si moltiplicano appelli, condanne e prese di posizione, nonché gli inviti a organizzarsi e rispondere. Sarà sufficiente?
Come un pugile groggy per i troppi pugni presi, ma che non vuole gettare la spugna, la comunità scientifica internazionale sta cominciando a prendere posizione contro le iniziative devastanti della nuova amministrazione Trump ai danni della ricerca, combinate con la politica dei tagli indiscriminati di Elon Musk.
Tra le prime a reagire è stata l’inglese Lancet con un editoriale pubblicato all’inizio di febbraio e di cui Scienza in rete ha proposto la versione in italiano. «La salute deve essere un bene sociale, un beneficio per le società, un motore delle economie e un percorso verso lo sviluppo», sottolineava la rivista, ribadendo anche che prendersi cura delle persone non è un atto di debolezza, ma di forza. In chiusura Lancet annunciava il proprio impegno a monitorare le azioni dell’amministrazione USA e le loro ricadute sulla salute della popolazione non solo americana, invitando la comunità scientifica a unirsi e a reagire.
Altrettanto dura l’altra testata inglese il British Medical Journal, che ha commentato: «Ogni centimetro lasciato libero dagli Stati Uniti nel ritirarsi dalle collaborazioni internazionali, diventa un centimetro conquistato per i nemici dichiarati di Donald Trump, come la Cina, e proprio nel campo dell'intelligenza artificiale e della ricerca medica. Le voci più sane negli Stati Uniti sostengono che “America First” non dovrebbe significare “America Alone”, ma la sanità mentale non è all'ordine del giorno. Imbavagliare gli scienziati o punirli per aver svolto il loro lavoro ha sinistri echi storici». Ora, a poco più di un mese di distanza dall’insediamento di Donald Trump, si aggiungono anche le due grandi testate scientifiche generaliste, Science e Nature.
Siamo di fronte a «un assalto senza precedenti alla scienza, alle istituzioni di ricerca e alle organizzazioni internazionali vitali», scrive Nature, che riepiloga quello che il mondo intero ha visto accadere a velocità sorprendente: la firma di ordini esecutivi che hanno cancellato o congelato decine di miliardi di dollari in finanziamenti per la ricerca; migliaia di licenziamenti nelle agenzie federali; l'imposizione di restrizioni "orwelliane" sulla ricerca, inclusi divieti di studi che menzionano parole relative a sesso, genere, razza e disabilità; la sospensione delle commissioni di revisione delle sovvenzioni di ricerca dei National Institutes of Health (NIH); il congelamento dei fondi dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID), con conseguenze drammatiche sull'assistenza globale; la cancellazione dei finanziamenti federali per progetti internazionali sul cambiamento climatico. Nonché l’annuncio, uno dei primi, che gli Stati Uniti avrebbero lasciato l’OMS. Scienza in rete ne ha parlato qui e qui.
Conseguenze globali
Nature, che quest'anno celebra i suoi 155 anni, ricorda come per gran parte di questo periodo gli Stati Uniti siano stati leader globali nella ricerca, ma avverte: «La nuova amministrazione sembra intenzionata a consegnare imprudentemente tutto ciò alla storia».
Imprudentemente, perché le conseguenze di questo attacco alle istituzioni e alle attività della scienza avranno ricadute inevitabili e pesanti sugli Stati Uniti, tuttavia, le decisioni americane hanno anche ripercussioni globali. Anzi, sono proprio queste a manifestarsi per prime: «A causa del congelamento dei fondi USAID almeno un milione di donne in tutto il mondo hanno perso l'accesso all’offerta contraccettiva», scrive Nature. L'agenzia, che nel 2023 ha erogato 72 miliardi di dollari in assistenza internazionale, vede ora la maggior parte dei suoi 10.000 dipendenti in congedo forzato. Anche il finanziamento dell'Emergency Plan for AIDS Relief, che ha erogato più di 100 miliardi di dollari per la prevenzione e il trattamento dell'HIV/AIDS dal 2003, è in bilico. E non ci si fermerà qui, perché ogni giorno nuovi ordini esecutivi e nuove limitazioni si aggiungono a quelle messe in fila da Nature.
L’attacco alle libertà accademiche
«Non tutti sanno che, dopo lo smantellamento brutale del sistema pubblico della ricerca e il drastico ridimensionamento del dipartimento dell’istruzione, è iniziato il definanziamento delle università private americane», allarga il discorso Fabio Sabatini, ordinario di Economia politica alla Sapienza sulla sua newsletter, con un lungo commento intitolato “Guerra alla scienza”.
Negli Stati Uniti, la parte dei finanziamenti pubblici alle università per il funzionamento corrente, i cosiddetti overhead, oscilla tra il 50 e il 70% dei fondi che ricevono. L’amministrazione Trump ora ha stabilito che la quota dei costi indiretti non potrà superare il 15%, avvicinando la percentuale a quelle in uso in Italia e nei paesi europei, ma a fronte di un’altra organizzazione.
«Sembra un cavillo, invece è un cataclisma per le università americane. Per dare un’idea delle proporzioni, un ateneo abituato a ricevere ogni anno 500 milioni di dollari in fondi di ricerca con overhead al 55% si troverebbe a perdere 200 milioni l’anno», conferma Sabatini.
Non sarà facile per gli atenei adattare i propri budget, ristrutturandoli per affrontare questa disastrosa perdita di risorse perché la maggior parte delle disponibilità finanziarie derivano da donazioni vincolate a obiettivi di ricerca specifici. Così sarà inevitabile per le università adottare una politica drastica di riduzione dei costi, licenziando docenti e ricercatori, bloccando le nuove assunzioni e abbassando nel complesso manutenzione e servizi per gli studenti.
«La ricerca biomedica soffrirà più di altri settori, perché richiede le attrezzature più costose e dipende fortemente dai finanziamenti del NIH (National Institutes of Health), il primo ente per il quale l’amministrazione ha reso operativo il taglio degli overheads. Le economie locali ne risentiranno perché le istituzioni di ricerca sono datori di lavoro di dimensioni spesso rilevanti. Nel lungo periodo, il definanziamento rallenterà il progresso della ricerca di base», infierisce Sabatini nella sua analisi, ricordando anche l’inevitabile riduzione dell’assistenza sanitaria offerta alla popolazione più fragile dagli ospedali universitari.
Anche in ambito accademico, la preoccupazione per quanto sta accadendo negli Stati Uniti comincia finalmente a sostenere qualche iniziativa di protesta, come quella della Federazione europea delle accademie delle scienze e delle discipline umanistiche (Allea) che ha preso duramente posizione: «Il silenzio sulle minacce alla libertà accademica e alla collaborazione internazionale nella ricerca è assordante. Con questa dichiarazione, chiediamo ai governi nazionali e alle organizzazioni internazionali di stare dalla parte della comunità della ricerca per rimanere vigili su queste sfide. È giunto il momento di unire le forze», si legge nel comunicato rilasciato da Allea. La dichiarazione ha raccolto rapidamente l’adesione di oltre 40 istituzioni di ricerca europee.
Autolesionismo o disegno?
Insomma, sono ormai tante le voci che protestano contro le scelte di Trump, sottolineandone peraltro la logica autolesionista che nel medio e lungo periodo non potrà che danneggiare gli stessi Stati Uniti. Purtroppo questo succede quando l’obiettivo, quello vero, non è una supposta migliore efficienza o la riduzione degli sprechi. L’obiettivo è politico e il vicepresidente Jack Vance, che sembra interpretare il ruolo del mastino portavoce, lo ha dichiarato apertamente: «Le università e i professori sono il nemico».
L’obiettivo, quindi, è il pensiero critico, la capacità di indagare e contraddire una narrazione. Senza che sia necessario evocare i roghi nazisti dei libri o le cannonate talebane contro i Buddha di Bamiyan, dobbiamo renderci conto che i regimi autoritari hanno bisogno di coltivare l’oscurantismo, a dispetto delle ricadute negative che questo può generare.
Il discredito verso le competenze e le figure esperte, la propaganda e la disinformazione diffuse a piene mani, e soprattutto, oggi, la limitazione dell’accesso ai dati e alle pratiche di fact checking, sono tutti elementi che costruiscono il controllo. Ed è sufficiente: il percorso di Trump verso un regime autoritario non ha più bisogno di eliminare fisicamente gli oppositori come nei colpi di stato di una volta, basta esercitare il potere economico. Ce lo ricordano Steven Levitsky e Lucan A. Way in una bella analisi sulla rivista Foreign Affairs.
Perciò, benvenuti gli appelli, le proteste e gli inviti a unirsi e resistere, sono giusti e necessari. Basteranno?