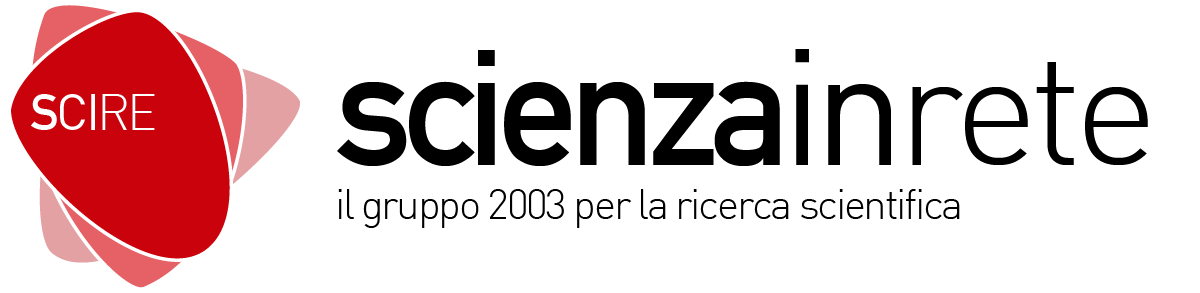La COP16 di Roma si è chiusa dopo tre giorni di intense negoziazioni con l'approvazione dei documenti su finanziamenti e monitoraggio, oltre alla definizione della roadmap che arriva fino al 2030. Un risultato migliorabile, ma che non era affatto scontato, una conquista fragile su cui bisogna lavorare.
La sessione bis della COP16 si è conclusa con la sospirata risoluzione dei nodi che erano ancora in sospeso per l’attuazione della strategia globale per la biodiversità. Il secondo appuntamento si è tenuto presso la sede della FAO a Roma, dal 25 al 27 febbraio, per riprendere il discorso interrotto bruscamente a Cali, in Colombia. Si è trattato di una COP asciutta, totalmente incentrata sulla contrattazione politica, senza spazi per eventi collaterali: una tre giorni intensissima, che ha portato a un emozionante accordo sui meccanismi di finanziamento e mobilitazione delle risorse nonché monitoraggio e rendicontazione dello stato di avanzamento.
«Siamo qui per trovare un consenso e approvare una policy veramente buona, basata anche sulla scienza e sul punto di vista di numerosi stakeholders, inclusi quelli che sono ogni giorno in prima linea a fronteggiare la crisi della biodiversità» ha detto nel suo discorso di apertura Susana Muhamad, presidente della COP, che ha fortemente voluto portare a termine, nonostante le fresche dimissioni da ministro dell’ambiente colombiano. «Questa policy ha il potere di tenere unito il mondo nonostante il contesto geopolitico attuale, e qui abbiamo l’opportunità di pianificare per il nostro futuro. Lo scopo della COP16 è di “fare pace con la natura” e dobbiamo concentrare tutti i nostri sforzi in questi tre giorni per riuscirci» ha continuato la presidente nell’inaugurazione. La potenza del multilateralismo in questi tempi di equilibri rovesciati è stato in effetti uno dei risultati più importanti della COP16, come ribadito da più voci nei discorsi di chiusura dei lavori, nelle prime ore del 28 febbraio. Dopo una lunga giornata trascorsa tra plenarie ritardate, gruppi ristretti di lavoro, consultazioni a porte chiuse e negoziazioni informali, verso mezzanotte tutti i principali nodi sono stati sciolti e le misure approvate, tra scroscianti applausi. A riceverli, un’emozionata Muhamad e il suo commosso team “femminile” come lei stessa ha sottolineato. La presidente ha dimostrato una straordinaria abilità diplomatica e una fortissima determinazione, riuscendo a ottenere un risultato tutt’altro che scontato.
Il nodo cruciale: la mobilizzazione dei fondi
Che non sarebbe stato facile raggiungere gli accordi, malgrado una piena volontà di riuscirci, era chiaro fino dall’inizio. E l’intensa tre giorni è stata una sofferta revisione punto per punto dei documenti sulle finanze e il monitoraggio, in particolare il documento sulla mobilizzazione delle risorse, che in una animata negoziazione ha visto un pesante rimaneggiamento degli articoli 19 - 25 che definiscono la roadmap per lo stanziamento e l’accesso ai fondi, e che è stato approvato con una ovazione della sala alle 22:33 del 27 febbraio.
Il Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework prevede infatti lo stanziamento di almeno 200 miliardi di dollari all’anno per la biodiversità, e un contributo a favore dei paesi meno sviluppati e gli Stati insulari di 20 miliardi di dollari all’anno per il 2025 e 30 miliardi entro il 2030. Non solo, si dovrà lavorare per ridurre entro il 2030 di 500 miliardi all’anno il gap che si crea con i sussidi alle attività che vanno a detrimento della biodiversità. I fondi saranno di provenienza mista: pubblici, privati, filantropici e da accordi bancari multilaterali, e dovrà essere supportato da un meccanismo di monitoraggio che garantisca efficacia e trasparenza. Uno dei nodi centrali delle negoziazioni è stata proprio l’architettura dei fondi. A oggi, infatti, le poche risorse mobilitate (siamo intorno ai 380 milioni di dollari) sono state versate nel Global Biodiversity Framework Fund, GBFF, istituito all’interno del Global Environmental Fund (GEF), un meccanismo finanziario ONU attivo dal 1991 per i progetti su clima e ambiente. Questa soluzione crea però un diffuso malcontento da parte di diversi paesi in via di sviluppo, che lamentano la difficoltà di accesso. In particolare, sono tagliati fuori i Paesi sanzionati dagli USA e i meccanismi attuali prevedono, tra le altre cose, la presenza di intermediari nella presentazione dei progetti da finanziare e una quasi impossibilità di accesso diretto ai fondi da parte dei popoli indigeni.
La decisione approvata prevede che ci si appoggi provvisoriamente ancora al GEF, rimanda alle successive COP la decisione su se creare un fondo a sé stante o restare in questo alveo, lavorando a una maggiore flessibilità. Rimandata alla COP17, che si terrà in Armenia nel 2026, anche la creazione di una istituzione finanziaria permanente per la gestione e il monitoraggio dei fondi, come previsto dall’articolo 21 della Convenzione, che dovrà essere pienamente operativa entro la COP19 del 2030. Questa istituzione farà capo alla Conferenza delle Parti, e dovrà operare garantendo trasparenza ed equità, supportando i popoli indigeni, i giovani e le donne. L'impegno è inoltre quello di lavorare per promuovere un confronto tra i ministri dell’ambiente e quelli delle finanze, e di collaborare con le istituzioni internazionali competenti per approfondire temi come la relazione tra la sostenibilità del debito e l’attuazione della Convenzione, il rapporto tra finanziamenti alla biodiversità e al clima e a come istituire una piattaforma di scambio di buone pratiche ed esperienze acquisite.
Fondi privati per l’uso delle risorse genetiche
La COP16 di Roma è stata l’occasione per formalizzare il Cali Fund, fondo legato ai benefici derivanti dall’uso delle risorse genetiche digitalizzate, le DSI (Digital Sequence Information), un risultato della prima parte dei negoziati in Colombia. Il Cali Fund sarà ospitato dall'Ufficio del Fondo Fiduciario Multi-Partenariato (MPTFO) in una partnership tra il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) e quello per l'Ambiente (UNEP), grazie a un accordo siglato il 24 febbraio a Roma. Il fondo beneficerà dei contributi dell’industria farmaceutica, cosmetica, nutraceutica e biotecnologica, che su base volontaria dovranno versare l’1% dei profitti o lo 0,1% del fatturato. L’accordo prevede che almeno il 50% di questo fondo vada direttamente ai popoli indigeni e alle comunità locali. Alla conferenza stampa di lancio, Astrid Schomaker, segretaria esecutiva della Convention on Biological Diversity (CBD) ha applaudito il fatto che, per la prima volta dalla nascita della Convenzione, un fondo globale, sotto l'egida della Conferenza delle Parti, riceverà contributi dal settore privato sotto forma di imposte sul reddito d'impresa generate grazie all'uso delle informazioni digitali sulle sequenze delle risorse genetiche: la formula è «prendi dalla natura e restituisci alla natura e a chi la protegge».
Resta da vedere quanto effettivamente le industrie saranno motivate a versare questo seppur modesto contributo, dato che la formula è del tutto volontaria. Schomaker ha sottolineato il ruolo delle pubbliche relazioni, suggerendo la presenza di alcune aziende già interessate e di altre che verranno attivamente contattate, ma restando vaga sui numeri effettivi. Si punta soprattutto sull’aspetto reputazionale e sulla esiguità del contributo nella contabilità aziendale complessiva, che secondo la CBD rappresenterebbe una situazione win-win per i privati interessati. A patto non si tratti però di puro greenwashing.
Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle azioni a supporto della biodiversità
Senza un monitoraggio dei progressi e dell’efficacia delle misure adottate, si rischia di vanificare gli sforzi di conservazione, ecco perché il tema della definizione degli indicatori da adottare e di un piano di reporting progressivo è cruciale. A Roma è stato approvato il PMRR: il meccanismo per la pianificazione, monitoraggio, reporting e revisione. Sono indicatori utili per i policy maker, che possono essere facilmente aggregati per fornire una misura globale dello stato di avanzamento, includono metriche biologiche e di sostenibilità, ma anche economiche, e coprono i 23 target previsti dal piano d’azione decennale, il Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Un altro importante accordo è quello di arrivare alla prossima COP con un reporting intermedio, che permetta di aggiustare il tiro sia in termini di misure di attuazione, sia in termini di qualità degli indicatori utilizzati. Le singole parti dovranno assicurare lo svolgimento dei piani d’azione nazionali, coinvolgendo in modo partecipativo tutte le istituzioni pertinenti, i popoli indigeni e le comunità locali, le donne, i giovani e gli stakeholder rilevanti.
La conservazione della biodiversità richiede partecipazione reale
La COP di Cali si era presentata come “la COP delle persone”, per evidenziare la strettissimo legame tra la conservazione della biodiversità e l’inclusione, e in particolare la necessità di dare spazio alle minoranze, ai popoli indigeni, alle donne, ai giovani. Ma i tre giorni romani sono stati dedicati interamente alla politica istituzionale, a causa della stringatezza dei tempi e della necessità di chiudere il negoziato, come la stessa Susana Muhamad ha sottolineato, scusandosi, a conclusione della plenaria. Era già passata di gran lunga la mezzanotte quando la presidente ha riconosciuto di non aver coinvolto nelle discussioni i gruppi osservatori presenti riconosciuti dalla Convenzione, che includevano la Global Youth Biodiversity Network, coalizione dei giovani attivisti, la CBD alliance, che riunisce diverse ONG, e la CBD Women's Caucus, focalizzata sul rispetto delle questioni di genere. I rappresentanti dei tre gruppi hanno potuto quindi solo esprimersi in plenaria ad avvenuta approvazione dei risultati. La rappresentante del Women’s Caucus con voce tremante di rabbia ha ribadito che «i diritti umani sono imprescindibili, e tutti i partner devono impegnarsi a raggiungerli, perché senza di essi non esiste un vero multilateralismo». In generale tutti i gruppi hanno insistito sulla necessità di un effettiva inclusione di tutte le parti della società e hanno ribadito l’urgenza di un meccanismo di accesso diretto alle risorse finanziarie da parte dei popoli indigeni, che supporti il loro ruolo di custodi della biodiversità.
Gli attivisti del Global Youth Biodiversity Network, che riunisce 280 associazioni provenienti da oltre 140 Paesi e conta più di 1,2 milioni di soci tra i 18 e 35 anni, hanno fatto un flashmob il 26 febbraio, proprio per richiamare attenzione sulla necessità di avere voce all'interno della COP, come era successo a Cali. «Una cosa che si tende a dimenticare è che sono i giovani che trainano la ricerca scientifica» afferma Cristina Cipriano, coordinatrice del capitolo europeo del network. «Tanti di noi sono ricercatori e questo è molto importante. Chi meglio di noi è informato su queste questioni? Chi meglio di noi può spingere per una politica che sia più inclusiva e che tenga conto degli ultimi risultati scientifici? Un errore che si tende a fare molto spesso in ambito politico, in generale, è quello di pensare che una persona giovane non abbia esperienza. In realtà sono proprio le persone giovani a volte quelle più aggiornate e che quindi possono dare un input sulla direzione in cui vogliamo che il mondo vada, ancora più di valore proprio perché si tratta del mondo che ereditiamo noi. Quindi serve un dialogo intergenerazionale reale, che quando ci sediamo ai tavoli politici ci venga data la parola non come contentino, ma in maniera reale, e venire riconosciuti davvero come degli stakeholder estremamente importanti».
Un futuro biodiverso?
Susana Muhamad ha dichiarato in conclusione che i lavori della COP16 hanno dato “muscoli, gambe e braccia” al Global Biodiversity Framework. È sicuramente vero che si poteva essere più ambiziosi di così, che si poteva fare meglio, ma in un momento geopolitico come quello attuale, l’applauso commosso all’ultimo colpo di martelletto che sanciva la fine delle negoziazioni e l’adozione del programma di lavoro è stato sicuramente un momento emozionante e che fa sperare in un futuro migliore, anzi lo fa sembrare possibile. Di sicuro colpisce tantissimo l’assenza del ministro dell’ambiente italiano, a sancire la sempre scarsissima attenzione politica verso i temi della conservazione nel nostro Paese, e stride con il discorso della rappresentante dell’UE Jessica Roswall, che ha commentato che, una volta raggiunto l’accordo multilaterale, ora la palla passa ai singoli stati, che devono lavorare e includere la società civile nel processo.
In molti hanno lamentato una scarsa attenzione mediatica, ma in realtà la COP16 ha avuto molto più riverbero delle precedenti, la parola biodiversità, una semi-sconosciuta in Italia, ha rimbalzato tra televisioni e radio nazionali e locali. Può essere un nuovo stimolo da sfruttare per cercare di restituire il bellissimo significato che questa parola racchiude, nel cercare di fare leva sulla biofilia, la profonda affinità con il mondo naturale, di cui parlava il grande ecologo Edward O. Wilson, colui che ha sdoganato il termine biodiversità al di fuori del contesto accademico. In tempi bui si tende a ridisegnare le priorità, affidandole alle contingenze del momento. Ma le crisi degli ecosistemi non rallenterà, anzi al contrario accelererà, se ci volteremo per l’ennesima volta dall’altro lato, fingendo che non ci riguardi, che non sia una responsabilità nostra assicurare la vitalità degli ecosistemi, la sopravvivenza di miriadi di forme di vita che interagiscono e danno forma al pianeta.
La COP16 disegna una ossatura, per quanto imperfetta e fragile per un futuro migliore, che assicuri la diversità dei viventi tutti, e sta anche a ognuno di noi pretendere che prenda forza e si tramuti in una azione reale e non rimanga un esercizio di stile. Di quelli ne abbiamo davvero visti troppi.